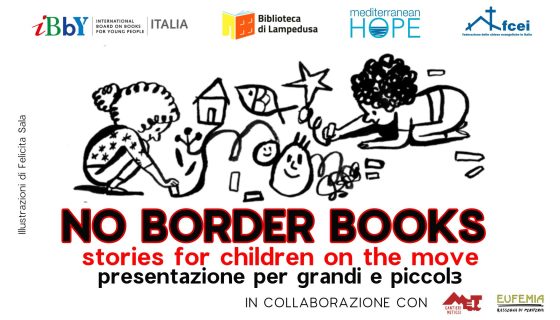- Mediterranean Hope - Federazione delle chiese evangeliche in Italia
- mh@fcei.it
Punto e a capo
La rubrica “Lo sguardo dalle frontiere” è a cura degli operatori e delle operatrici di Mediterranean Hope (MH), il progetto sulle migrazioni della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Questa settimana “Lo sguardo” proviene da Lampedusa ed è stato scritto da Marta Barabino
16 Aprile 2021. Lampedusa-Catania-Roma-Genova
Una decina di ore in viaggio, partire all’una e arrivare alle undici, un viaggio che definiremmo “infinito”. Questa volta non è l’itinerario di chi parte dalle coste del Nord Africa, è il mio.
Però su tre aerei diversi, con ben due valigie, e un posto riservato proprio per me.
Sto tornando a casa.
Si conclude il primo capitolo della “mia” Lampedusa, sto già aspettando di iniziare il prossimo.
In questo viaggio “infinito” ho il tempo pensare, piangere, ridere, chiamare amici e i miei genitori. Li tengo aggiornati in tempo reale, nel momento in cui le ruote dell’aereo toccano terra, attivo la connessione e invio “atterrata adesso, tutto bene. Viaggio tranquillo”. Perché è normale che il viaggio sia tranquillo, come potrebbe andare altrimenti? Si dà per scontato l’arrivo.
 Sono a Catania quando leggo la notizia di un naufragio, almeno 21 le vittime davanti alle coste Tunisine. Per quelle persone l’arrivo non era scontato, neanche per idea. Non lo è stato per chi è partito prima, né lo sarà per chi partirà.
Sono a Catania quando leggo la notizia di un naufragio, almeno 21 le vittime davanti alle coste Tunisine. Per quelle persone l’arrivo non era scontato, neanche per idea. Non lo è stato per chi è partito prima, né lo sarà per chi partirà.
Penso al libro di Erri De Luca, Solo andata. È un viaggio a senso unico quello in mare, che se va bene non ci si guarda più indietro, se va male si smette di esistere.
Il mio è un ritorno, cos’è un ritorno per chi abbandona casa? Un miraggio, forse. Neanche un’opzione, spesso.
Oltre a tutti i miei vestiti, le scarpe, i libri, porto via con me un bagaglio grosso, che non so ancora bene se e quando disferò; forse resterà sempre mezzo pieno, mezzo vuoto, lo riempirò di nuovo e lo svuoterò piano piano. Dentro ci sono il mare, il sale. C’è l’odore di nafta della banchina, le cime ammucchiate, consumate dall’acqua, ci sono le barche sommerse e quelle ammassate sulla terra, ci sono i piedi scalzi e magri di chi ha calpestato il deserto e poi la ghiaia del molo, c’è il fruscìo delle coperte termiche.
Ci sono le chiamate di notte, c’è l’adrenalina e c’è l’ansia che chiude lo stomaco di tutte le volte in cui vedo una barca stracolma avvicinarsi a terra. Ci sono i pupazzi dei bambini, i “ciao” fatti con la mano, da lontano, il tè caldo sempre troppo poco zuccherato. L’odore della fatica di chi ha resistito, gli sguardi eloquenti di chi mi ha accompagnata in questi mesi, gli innumerevoli caffè a tutte le ore, le mascherine, i guanti. C’è la “tesi vista mare”, come mi piace chiamarla, i carnet di appunti, mille fotografie.
Ci sono fiumi di lingue diverse, corsi improvvisati di arabo, bengalese, tigrino, per imparare a dire “grazie” e “ciao” nella loro lingua, le risate che suscita il mio modo goffo di ripetere quei suoni. C’è la paura che qualcuno sia rimasto indietro, che non tutti siano riusciti ad arrivare, che qualcuno si metta in viaggio senza sapere che domani si alza il vento. Le decine di donne incinte, i tessuti colorati che avvolgono i loro corpi o quelli dei loro figli, i giubbotti di salvataggio arancioni ammassati sulle barche e sul molo. C’è la stanchezza delle notti non dormite, in cui si va avanti per inerzia, finché ci sono risorse, finché c’è bisogno.
Ci sono le passeggiate e i tramonti, le lezioni di francese, i racconti di chi vive l’isola ogni giorno, i vestiti stesi che si asciugano al vento. La sabbia, i bagni in mare in ogni stagione, la chitarra e le canzoni, il gelato al pistacchio.
I nomi del vento, la nazionalità di chi arriva, le città di partenza, le storie dietro i volti, i nomi prima dei numeri.
 In particolare, mi porto dietro la consapevolezza che la fortuna è tutto un fatto di geografia.
In particolare, mi porto dietro la consapevolezza che la fortuna è tutto un fatto di geografia.
Difficilmente dimenticherò quel ragazzo, di cui mai saprò il nome, che a stento riusciva a stare in piedi una notte di febbraio.
“Quanti anni hai?” Gli chiedo in inglese. Esita, lo scrive con il dito sulla gamba, non sa dirlo in inglese, lo dice in arabo e riesco a cogliere solo “arbahah”, quattro. “Ventiquattro?” annuisce con convinzione. “Anche io!” rispondo, con un entusiasmo ingiustificato, come se questo ci rendesse più vicini in qualche strano modo. È forse l’unica cosa che abbiamo in comune io e lui, che poi neanche è vero, io ancora li devo compiere 24 anni.
Questo scatena però in me una tempesta incontrollata di rabbia, tristezza, shock. Lui ha ventiquattro anni proprio come me e apparteniamo a due universi lontani, remoti. E ci incontriamo seduti per terra, sotto le stelle di una domenica notte a Lampedusa, dopo che lui ha attraversato l’Africa e il mare.
Gli tengo una mano sulla schiena, per sentire che è lì e fargli sentire che sono lì, anche se non parliamo. Mi sembra l’unico modo possibile per esserci, per uno sconosciuto con il quale riesco a comunicare a fatica.
Ho visto e sentito il distacco con cui lui – e con lui centinaia – è stato trattato. Ho avuto voglia di gridare e di piangere, piangere di ingiustizia.
Ho letto questo, in un libro del 1976[1]: abbiamo cento tribù da trasformare in un’unica nazione. Quanto ci vorrà? Nessuno può dirlo. Dobbiamo disabituare la gente all’odio. Dobbiamo introdurre l’abitudine di darsi la mano.
Non ho altro da aggiungere, solo la speranza e le mie mani.
[1] Ancora un giorno, Ryszard Kapuściński, 1976.